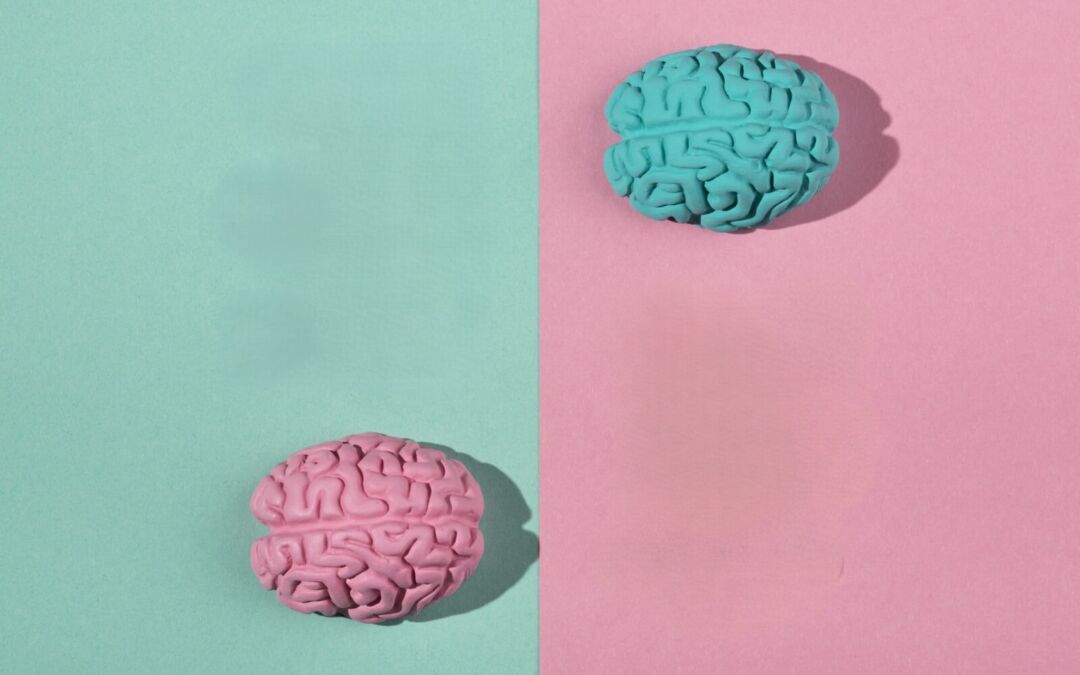Il cervello, quello straordinario organo che definisce chi siamo, potrebbe funzionare in modo diverso a seconda del genere? Questa domanda apre la porta a uno dei campi più affascinanti e complessi delle neuroscienze. Per anni, lo studio delle differenze tra uomini e donne ha oscillato tra due posizioni opposte: da un lato, l’idea che tutto sia determinato dalla biologia; dall’altro, la convinzione che ogni differenza sia il prodotto della società e della cultura. Oggi, le evidenze suggeriscono una realtà più sfumata: lo sviluppo del cervello umano è influenzato da biologia, ambiente, cultura, genetica ed esperienza.
Prima di approfondire il discorso, è necessario chiarire il significato di alcuni termini. Tradizionalmente, la parola “sesso” si riferisce alle differenze biologiche determinate da cromosomi, ormoni e anatomia, mentre con “genere” si intendono gli aspetti socio-culturali costruiti attorno a queste caratteristiche. Tuttavia, molti studiosi sottolineano come questa distinzione netta sia artificiale e riduttiva, poiché le differenze che osserviamo tra uomo e donna sono il risultato dell’interazione tra fattori biologici e ambientali.
Biologia e ambiente nelle differenze di genere del cervello
Le differenze tra i cervelli maschili e femminili iniziano prima della nascita. Durante le prime settimane di sviluppo embrionale, gli organi riproduttivi sono uguali per entrambi i sessi, ma intorno alla sesta-settima settimana, nei feti con cromosomi XY, il gene SRY attiva la produzione di testosterone, portando alla formazione dei testicoli. Nei feti con cromosomi XX, in assenza di questo gene, si sviluppano invece le ovaie, che in seguito produrranno estrogeni e progesterone e influenzeranno lo sviluppo cerebrale, modulando la struttura e la funzione del sistema nervoso. L’effetto degli ormoni sessuali femminili non si limita alla fase prenatale: per tutta la vita, estrogeni e progesterone continuano a modellare la plasticità neuronale, influenzando la comunicazione tra i neuroni e interagendo con i neurotrasmettitori responsabili dell’umore, della memoria e della regolazione cognitiva.
Dal punto di vista anatomico, gli uomini tendono ad avere un volume cerebrale maggiore, mentre le donne mostrano un flusso sanguigno cerebrale più elevato e più connettività tra gli emisferi. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che i cervelli maschili siano strutturati per favorire la connettività tra percezione e azione coordinata, mentre quelli femminili favoriscano l’integrazione tra pensiero analitico e intuitivo.
Le differenze di genere si notano anche nelle abilità cognitive. In linea di massima, gli uomini mostrano più variabilità nelle capacità matematiche e spaziali, con una maggiore presenza sia tra i migliori che tra i peggiori nei test, mentre le donne eccellono nelle competenze verbali e di scrittura. A scuola, le ragazze tendono a prendere voti più alti, ma nei test standardizzati i ragazzi generalmente ottengono punteggi migliori. Un esempio è la rotazione mentale, in cui gli uomini superano le donne, un’abilità che permette di immaginare e manipolare oggetti tridimensionali, spesso associata al successo nelle materie STEM, come ingegneria e matematica.
Ma queste differenze da cosa dipendono? L’ambiente in cui cresciamo, le esperienze che viviamo e le aspettative sociali a cui siamo esposti interagiscono costantemente con la nostra biologia, influenzando lo sviluppo e la funzione cerebrale.
La neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di riorganizzarsi in risposta alle esperienze, è centrale in questo processo. L’ambiente può influenzare la biologia attraverso cambiamenti nella struttura e funzione cerebrale, mentre la biologia può influenzare il tipo di ambienti che preferiamo e come li percepiamo. Per esempio, una ragazza incoraggiata a giocare con costruzioni e videogiochi tridimensionali migliorerà le sue capacità spaziali, potenzialmente provocando cambiamenti fisici nel cervello grazie alla neuroplasticità. D’altro canto, un bambino con un livello elevato di testosterone potrebbe essere naturalmente più propenso a usare giochi che richiedono manipolazione spaziale, rafforzando ulteriormente queste abilità. Anche le esperienze personali hanno il loro peso: una persona può scegliere di conformarsi o ribellarsi agli stereotipi. Una ragazza con talento matematico che riceve incoraggiamento da insegnanti e genitori, ad esempio, potrebbe sviluppare un forte interesse per la disciplina, superando i preconcetti culturali.
Le differenze di genere nelle malattie neurodegenerative
Il genere influenza anche la vulnerabilità alle malattie neurodegenerative. Nel mondo, le donne con la malattia di Alzheimer sono il doppio degli uomini, e questo non dipende solo dalla loro maggiore longevità. Un ruolo chiave lo gioca il gene APOE ε4, che nelle donne accelera l’invecchiamento cellulare in modo più marcato. Gli estrogeni normalmente proteggono il cervello, aiutando i neuroni a comunicare meglio e riducendo lo stress cellulare. Entrando in menopausa, la diminuzione degli estrogeni rende le donne più vulnerabili: il metabolismo cerebrale cambia e si formano più facilmente le placche amiloidi tipiche della malattia di Alzheimer.
Ma c’è un altro aspetto interessante: le donne, rispetto agli uomini, riescono a compensare meglio i primi segni della malattia, ottenendo risultati migliori nei test di memoria verbale. Tuttavia, questa capacità può ritardare la diagnosi, rendendo più difficile intervenire precocemente. Inoltre, a livello cerebrale, le donne tendono a sviluppare livelli più elevati di proteina tau, un altro segnale distintivo della malattia.
Inoltre, il sistema immunitario femminile è più reattivo rispetto a quello maschile. Questo significa che le donne producono più anticorpi e hanno una risposta infiammatoria più intensa. Da un lato questa caratteristica le aiuta a difendersi meglio dalle infezioni, dall’altro può esporre il cervello a un’infiammazione cronica più prolungata, favorendo la progressione della malattia di Alzheimer.
La malattia di Parkinson, al contrario, è più diffuso tra gli uomini, che rappresentano circa il 60% dei pazienti. La malattia – che colpisce il sistema dopaminergico, ovvero i neuroni che producono dopamina – causa problemi motori e, nel tempo, anche a deficit cognitivi.
Anche in questo caso, gli ormoni giocano un ruolo importante. Gli estrogeni sembrano avere un effetto protettivo sulla dopamina, il neurotrasmettitore che viene progressivamente a mancare nel Parkinson, in relazione al danno alle cellule che lo producono. Questo potrebbe spiegare perché le donne sono meno colpite. Tuttavia, quando si ammalano, tendono a manifestare sintomi diversi: mentre gli uomini sviluppano più rigidità e difficoltà motorie avanzate, le donne presentano più spesso tremori e instabilità posturale.
Le differenze emergono anche nei sintomi non motori. Le donne con malattia di Parkinson sono più inclini a soffrire di ansia, depressione, affaticamento e disturbi gastrointestinali, mentre gli uomini hanno un rischio maggiore di sviluppare demenza e deficit cognitivi più rapidamente. Alcune ricerche suggeriscono anche che le mutazioni genetiche, come quelle nel gene GBA, possano influenzare la gravità dei sintomi in modo diverso nei due sessi.
Non è solo questione di biologia
Non è solo la biologia a fare la differenza. Anche le condizioni di vita e le abitudini giocano un ruolo importante nel rischio di sviluppare malattie neurodegenerative. Per esempio, l’istruzione e il lavoro influenzano la riserva cognitiva, cioè la capacità del cervello di resistere ai danni. In passato, le donne hanno avuto meno accesso all’istruzione rispetto agli uomini, un fattore che potrebbe aver contribuito al loro maggiore rischio di malattia di Alzheimer. Tuttavia, con l’aumento del livello di istruzione femminile nelle nuove generazioni, è possibile che questa tendenza si riduca nei prossimi decenni.
Anche l’attività fisica ha un impatto significativo. Le donne tendono a essere meno attive rispetto agli uomini, ma quando fanno esercizio ne traggono benefici maggiori, anche in età avanzata o se già affette da deficit cognitivi.
La dieta è un altro fattore da considerare: l’obesità aumenta il rischio di demenza, specialmente negli uomini, mentre regimi alimentari sani, come la dieta mediterranea o la dieta MIND, sembrano offrire una maggiore protezione alle donne. Infine, alcuni studi suggeriscono che il consumo di legumi e pesce possa ritardare la menopausa, migliorando così la salute del cervello nel lungo termine.
Studiare le differenze biologiche tra uomini e donne non significa alimentare stereotipi, ma aprire nuove strade per la medicina. La ricerca scientifica dimostra che riconoscere la diversità biologica può migliorare significativamente la diagnosi, la cura e la prevenzione delle malattie. Nell’era della medicina personalizzata, ignorare le differenze di genere significherebbe rinunciare a preziose opportunità di sviluppare trattamenti più precisi ed efficaci, capaci di rispondere in modo più mirato alle caratteristiche uniche di ciascuno di noi.
Fonti
Seminario “DiversaMENTE: differenze cerebrali tra uomo e donna in salute e malattia“. Relatrice principale la dottoressa Silvia Paola Caminiti, ricercatrice in Neuropsicologia e neuroscienze cognitive presso il Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia.