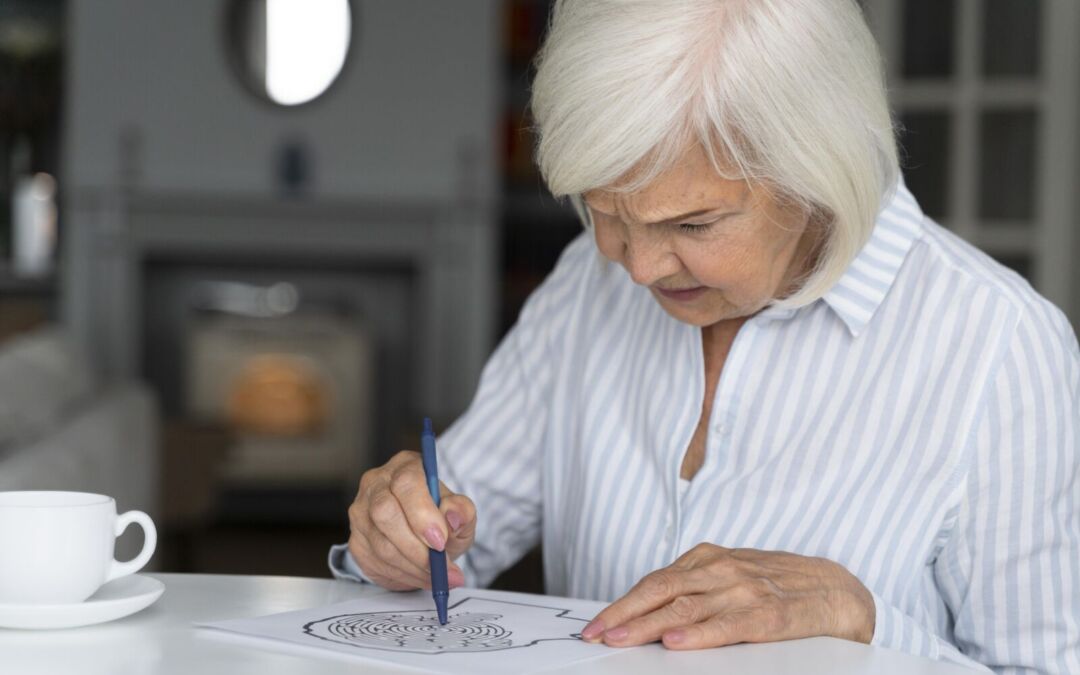La popolazione anziana è spesso considerata come la custode della memoria storica e familiare, e nell’immaginario comune la vecchiaia è associata alla saggezza, come ci insegnano molti personaggi iconici di film e serie TV che incarnano il ruolo del “saggio”. Come dimenticare, ad esempio, la celebre frase pronunciata dall’anziano maestro del cartone di Kung Fu Panda:
Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C’è un detto: «Ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono: per questo si chiama presente».
Questa percezione della terza età come giudizio e ponderatezza si basa su una realtà tangibile: la ricchezza di esperienze e conoscenze accumulate nel corso della vita costituisce un patrimonio inestimabile per le generazioni future. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, il processo di invecchiamento influenza inevitabilmente i ricordi e, in molti casi, è associato a un declino delle capacità mnemoniche.
Questo fenomeno, benché spesso fisiologico, può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Il naturale deterioramento delle capacità cognitive può andare da lievi difficoltà di memoria fino a vere e proprie patologie, come la malattia di Alzheimer, che compromette gravemente la capacità di ricordare. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le demenze rappresentano sindromi croniche che causano un declino progressivo delle funzioni cognitive, tra cui memoria, linguaggio, orientamento e giudizio.
Nonostante l’invecchiamento comporti cambiamenti significativi nel corpo e nel cervello, la memoria può essere allenata, a meno che non vi siano patologie gravi che ne alterino il funzionamento. In questo articolo, spiegheremo brevemente come funziona la memoria e proporremo esercizi e strategie per mantenerla attiva.
Facciamo una prova! Ecco il primo esercizio.
Leggi questi quattro oggetti e tienili a mente per il resto dell’articolo. Ti verrà chiesto di ricordarli alla fine della lettura:
Mucca, matita, aspirapolvere, fiore

La funzione della memoria
La memoria è un complesso sistema che costituisce la base per le nostre azioni, decisioni e connessioni sociali. Secondo l’American Psychological Association, essa è “la capacità di conservare informazioni o rappresentazioni di esperienze passate, sulla base di processi mentali di apprendimento o codifica, mantenimento nel tempo e recupero o riattivazione dei ricordi”.
La memoria svolge un ruolo cruciale nella percezione e nell’azione, come sottolineato da Arthur M. Glenberg, Professore di Psicologia dell’Arizona State University. Egli sostiene che la memoria mischia le immagini della nostra mente interagendo con le caratteristiche reali dell’ambiente per muoversi all’interno della realtà. In questo contesto, la memoria non è solo un archivio passivo, ma un sistema dinamico che modella il significato dell’ambiente in base alle esperienze passate.
In effetti, ripercorrendo le tappe dell’evoluzione, l’umanità si è da sempre dovuta adattare al mondo esterno, che Glenberg descrive come “pericoloso” e “tridimensionale” (a differenza delle immagini nella nostra mente). È chiaro che la sopravvivenza richiede la capacità di navigare nell’ambiente e, altrettanto chiaramente, il nostro sistema percettivo si è evoluto proprio per questo.
Ogni giorno, ad esempio, dobbiamo scegliere la strada per casa (in quale via è), oltre a evitare gli ostacoli sul nostro cammino (una macchina, un cantiere, etc.), stare distanti da un luogo pericoloso, o da una persona che magari non ci sta simpatica. Questo tipo di capacità di scelta richiede un sistema di memoria e per tale motivo l’oblio non è per forza un fatto negativo, ma è funzionale proprio a mantenere solo le informazioni necessarie alla nostra quotidianità.
Contestualizzazione e memoria
Perché ricordiamo alcuni eventi della nostra vita e ne dimentichiamo altri? La memoria è influenzata da numerosi fattori. Spesso ricordiamo luoghi o esperienze in base a come le abbiamo apprese, perché il contesto di apprendimento gioca un ruolo fondamentale. Questo contesto comprende:
- L’ambiente fisico: il luogo in cui abbiamo vissuto o appreso un’esperienza.
- Gli elementi associati: oggetti, suoni o odori presenti in quel momento.
- Lo stato emotivo: le emozioni provate durante l’evento.
- Il contesto cognitivo: le conoscenze già attivate durante l’apprendimento.
Facciamo un esempio: ricordi cosa stavi facendo lo scorso 11 settembre?
Invece, ricordi cosa stavi facendo l’11 settembre 2001, quando si è verificato l’attacco alle Torri Gemelle? È probabile che tu possa richiamare alla mente il luogo in cui ti trovavi o il sentimento di paura provato.
Questi elementi influenzano profondamente la nostra capacità di recuperare informazioni, dimostrando che la memoria è un processo dinamico e strettamente legato al contesto.
Tipi di memoria e loro caratteristiche
La memoria umana può essere suddivisa in diverse categorie, ognuna con caratteristiche e funzioni specifiche:
- Memoria a breve termine: immagazzina informazioni per un tempo limitato, generalmente finché si mantiene l’attenzione sullo stimolo.
Prova a memorizzare queste lettere per 5 secondi:
P G L F E S R A
Riesci a ricordarle senza rileggerle? Puoi provare questa strategia: raggruppa le lettere in modo che formino delle parole: PGL = pugile, FESRA = festa . In questo modo, ti basterà richiamare alla mente l’immagine di un pugile che va a festeggiare.
- Memoria a lungo termine: conserva informazioni per periodi più lunghi, da mesi a tutta la vita.
Per esempio: ricordi le date di inizio e fine della seconda guerra mondiale?
Oppure: come si prepara un ottimo risotto con i funghi?
La memoria può essere suddivisa in memoria esplicita e memoria implicita. La memoria esplicita riguarda i ricordi coscienti di fatti, eventi e persone; mentre la memoria implicita permette l’apprendimento di abilità motorie o schemi di comportamento, come andare in bicicletta.
Lo psicologo e neuroscienziato Endel Tulving ha proposto una classificazione ulteriore dei sistemi di memoria:
- Memoria procedurale: alla base della gerarchia, riguarda le connessioni tra stimoli e risposte;
- Memoria semantica: permette di rappresentare mentalmente stati del mondo non immediatamente percepibili;
- Memoria episodica: consente di rievocare eventi personali con una dimensione temporale soggettiva.
La memoria non è composta da sistemi singoli e incomunicanti, infatti ciascuno “strato” è supportato da quelli sottostanti e ha funzioni uniche, che la rendono un complesso e affascinante ecosistema.
Strategie per stimolare la memoria negli anziani
Sebbene il declino della memoria sia fisiologico, ci sono strategie che possono aiutare a mitigare gli effetti dell’invecchiamento, come l’esercizio mentale (attività come l’enigmistica, la lettura e l’apprendimento di nuove competenze), l’attività fisica, la socializzazione e persino un’alimentazione equilibrata.
La memoria, in particolare quella a lungo termine, può essere allenata lavorando su tre fasi principali:
- La fase di codifica – È il momento in cui riceviamo un’informazione da ricordare. Registrarla in modo efficace può facilitarne il richiamo. Un trucco utile è immaginare collegamenti visivi tra gli elementi. Per esempio, immagina un pugile che si presenta a una festa: un’immagine vivida e insolita aiuta a fissare l’informazione.
- La fase di immagazzinamento – Qui l’informazione viene processata e conservata nella memoria. Ripetere più volte ad alta voce ciò che vuoi ricordare è una tecnica semplice ma efficace per consolidarla.
- La fase di recupero – È il momento in cui richiamiamo alla mente ciò che abbiamo memorizzato. Organizzare le informazioni fin dall’inizio in modo chiaro e ordinato può rendere tutto più semplice. Esistono anche strumenti specifici, chiamati mnemotecniche, che aiutano a memorizzare in modo creativo. Ad esempio:
- Rime: “Trenta giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre…”;
- Acronimi: come “UPO”: Università Piemonte Orientale;
- Acrostici: associare a ogni lettera di una parola una frase significativa, ad esempio “IRIS”: Interdisciplinarità, Ricerca, Integrazione col territorio, Sviluppo;
- Immagini interattive: creare immagini mentali che collegano i concetti da ricordare.
Vuoi provare subito queste tecniche? Leggi il seguente brano e mettiti alla prova rispondendo alle domande che troverai in fondo.
Nel 1969, l’astronauta Neil Armstrong divenne il primo uomo a camminare sulla Luna durante la missione Apollo 11. La famosa frase pronunciata da Armstrong, “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità,” è rimasta nella storia. La missione durò otto giorni e fu trasmessa in diretta televisiva, affascinando milioni di persone in tutto il mondo. Oltre ad Armstrong, gli altri membri dell’equipaggio erano Buzz Aldrin e Michael Collins, che orbitava attorno alla Luna.
Domande:
- In quale anno Neil Armstrong camminò sulla Luna?
- Qual era il nome della missione che portò l’uomo sulla Luna?
- Qual è la frase famosa pronunciata da Armstrong?
- Quanti giorni durò la missione Apollo 11?
- Chi erano gli altri due membri dell’equipaggio?
La tecnologia come supporto alla memoria
Le tecnologie digitali rappresentano un valido supporto per potenziare e allenare la memoria. Gli smartphone, ad esempio, offrono un’ampia gamma di applicazioni progettate per stimolare attenzione, concentrazione e capacità di problem solving, trasformando l’esercizio mentale in un’attività piacevole e accessibile. Dai giochi cognitivi alle app per gestire promemoria, queste risorse aiutano a mantenere il cervello attivo e a compensare eventuali difficoltà mnemoniche: leggi il nostro precedente articolo per approfondire.
E ora, mettetevi alla prova con due semplici esercizi:
- Guardate un telegiornale o leggete una notizia, e cercate di ricordare le informazioni principali: chi, dove, quando, e cosa è accaduto?
- Ripensate a un episodio della vostra vita e focalizzatevi sui dettagli: dove eravate, quando è successo, cosa stavate facendo, quali emozioni, odori o suoni avete percepito.
Un ottimo allenamento per il vostro “muscolo della memoria”!
Iniziative locali per mantenere la mente attiva
Vi ricordate i quattro oggetti che vi abbiamo chiesto di memorizzare all’inizio dell’articolo?
Esercizi come questo dimostrano che allenare la memoria, soprattutto durante la terza età, non è solo fondamentale per mantenere la mente attiva, ma può trasformarsi in un’attività divertente e stimolante, capace di arricchire le giornate e regalare momenti di leggerezza e soddisfazione.
Per approfondire, ricordiamo che sul nostro territorio esistono molte iniziative e associazioni dedicate alla memoria e all’invecchiamento attivo, anche se spesso restano poco visibili. Il Progetto Aging dell’Università del Piemonte Orientale, per esempio, promuove eventi e attività a tema memoria, mentre il Tavolo Tematico Anziani della città di Novara unisce volontari, enti del terzo settore e professionisti per progettare interventi a favore di un invecchiamento positivo. Un altro esempio virtuoso è l’Associazione A.M.A. Novara, attiva dal 1997, che offre supporto a malati di Alzheimer e ai loro familiari attraverso convegni, giornate di prevenzione e corsi di formazione.
Partecipare a queste iniziative rappresenta un’occasione preziosa per creare legami, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità che cresce insieme.
In definitiva, la memoria non è soltanto un archivio del passato, ma una bussola preziosa che orienta il nostro presente e traccia il cammino verso il futuro.
Riferimenti bibliografici
APA Dictionary of Psychology. Memory. Updated on 04/19/2018
Glenberg, A. M. (1997). What memory is for. Behavioral and brain sciences, 20(1), 1-19.
Tulving, E. (1985). How many memory systems are there?. American psychologist, 40(4), 385.
UniCampania. La memoria. Psicologia Generale